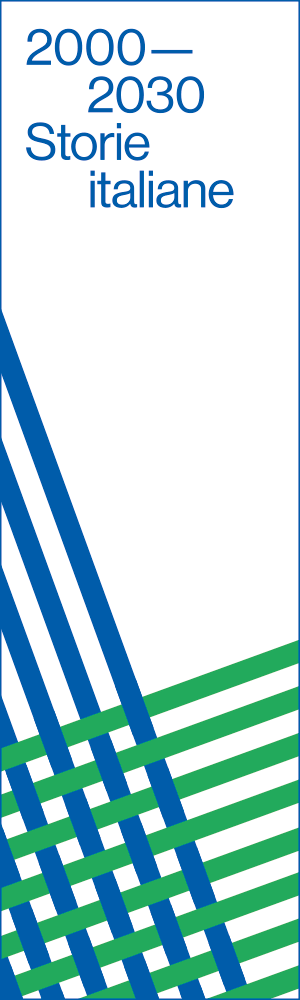La scuola incarna tre diverse missioni. La prima è quella di trasmettere il sapere, combattere l’ignoranza, nutrire lo spirito critico, fornire strumenti per dare un senso al mondo. Ecco allora i grandi della letteratura, i teoremi della geometria euclidea, i concetti intramontabili della filosofia, le lingue antiche. La seconda è quella di introdurre i giovani alle regole condivise e ai valori dominanti, e di prepararli al mondo del lavoro: ecco le gite d’istruzione, l’alternanza scuola-lavoro, l’informatica, l’inglese, il diritto e l’economia. La terza, quella di sviluppare il potenziale di chi un giorno sarà adulto, a ciascuno secondo la sua natura, i suoi bisogni e le sue caratteristiche: ecco i piani educativi personalizzati, l’insegnante come facilitatore, i programmi disciplinari che cedono il passo alle linee guida e ai curricola differenziati, le attività di orientamento. Questo in sintesi quanto sostengono o Angelo Gennaccaro e Leonardo Coletti in una loro articolata presa di posizione.
“Oggi non è chiara quale sia l’identità della scuola italiana, ma è evidente che gli interventi ministeriali degli ultimi venti anni siano avvenuti in nome della seconda e della terza missione: sull’orario curricolare sono piovute le educazioni stradale, affettiva e sessuale, l’area di progetto e la settimana di soggiorno linguistico. Poi sono piombati l’insegnamento di una materia in lingua straniera con metodologia CLIL, l’alternanza scuola-lavoro, l’educazione civica e, novità dell’ultima ora, l’orientamento. Infine, una spruzzatina (o meglio, una grandinata) di attività offerte da associazioni varie, corsi di teatro, olimpiadi di ogni materia, concorsi, uscite al cinema, settimane della scienza e altro che possono coinvolgere scuole intere, oppure classi o anche solo singoli studenti. Tutte iniziative interessanti, valide, validissime e che però, allocate nella settimana scolastica, sono un’entrata a gamba tesa sul sereno svolgimento dei programmi “ – spiegano i due candidati.
Appare evidente che percorso curricolare e attività integrative si escludono necessariamente a vicenda: se si dà più spazio alle seconde se ne toglie al primo, in un rapporto di proporzione inversa – chiariscono ulteriormente
Fin qui la scuola italiana. Se poi riflettiamo sulla scuola altoatesina della provincia di Bolzano, questo intasamento di attività raggiunge livelli ancora critici, a causa di altri fattori: le ore di seconda lingua e la settimana scolastica di cinque giorni invece dei sei nazionali (riduzione voluta sulla base di motivazioni puramente economiche, e non didattiche).
Ne consegue che più materie in meno tempo aumenta la densità dell’impegno. Meno ore di sonno, pasti frettolosi, studio superficiale. Per salvaguardarsi, lo studente delega le equazioni al computer, sostituisce la lettura del libro col riassunto online, condivide i compiti via whatsup: la scuola si riduce a una sequenza di obblighi cui adempiere, non un posto dove acquisire mezzi per dare significato al mondo e a se stessi. Non stupisce allora che le famiglie e gli insegnanti segnalino ragazzi in difficoltà, in preda all’ansia, anche tra quelli bravi, o meglio, quelli che vorrebbero avere il tempo per esserlo veramente ma non gli è concesso.
Non ci spieghiamo come gli assessori competenti e l’intendente scolastico, alle prese con tanto di rendicontazione e bilancio sociale, proprio non siano in grado di vedere questo enorme elefante nella stanza della scuola altoatesina!
La buona notizia, segnalano Gennaccaro e Colletti, è che, se veramente la si vuole, una soluzione c’è. Anche senza voler entrare nel merito di quale sia la missione primaria tra quelle descritte sopra,
si potrebbe adottare un compromesso pragmatico, basato sulla riorganizzazione dei tempi. L’anno scolastico dura 365 giorni ma, in pratica, è concentrato su 35 settimane di lezione, in cui confluiscono, sovrapponendosi, le attività di tutte e tre le missioni. Tolte 10 settimane di vacanze, ne restano altre 7 in cui la scuola non offre più nulla: non sono un po’ troppe? Perché allora non dedicare le 35 settimane allo studio vero e proprio, e poi nelle altre sette concentrare la seconda e la terza missione della formazione, magari in collaborazione e sussidiarietà con le associazioni e il mondo del lavoro e con personale più adeguato (psicologi, educatori, esperti vari) che non gli insegnanti?
Come effetto collaterale, questi ultimi tornerebbero a fare il mestiere che hanno scelto. La professione riacquisterebbe una sua precisa identità e una maggiore attrattività. Gli insegnanti potrebbero occuparsi a tempo pieno del loro sapere e interrogarsi seriamente su come trasmetterlo e renderlo vivo, e aggiornarsi. Proprio in tema di aggiornamento la Provincia dovrebbe fare uno sforzo in più. Gli insegnanti altoatesini non dispongono infatti della “carta del docente”, il cosiddetto bonus aggiornamento, ovvero un contributo annuo alle spese di formazione riconosciuto a tutti gli altri insegnanti della repubblica. Se vogliono aggiornarsi, maestri e professori altoatesini devono farlo rimanendo in provincia e se proprio desiderano frequentare un corso a Trento o a Innsbruck devono pagarselo interamente di tasca loro. Certo, non un bel segnale per una professione che deve formare i cittadini di un futuro che sarà sempre più senza confini.
Infine, un’altra soluzione da sperimentare è quella della scuola bilingue, che a questo punto andrebbe a soddisfare non solo le giuste esigenze identitarie degli studenti mistilingui e il desiderio di coloro che vorrebbero una preparazione bilingue, ma anche la richiesta di riduzione del carico orario settimanale, riallineandolo a quello nazionale: le varie discipline verrebbero svolte un po’ in italiano e un po’ in tedesco, due prime lingue, e non ci sarebbero le quattro/cinque ore di seconda lingua, permettendo così un po’ più di respiro all’orario settimanale.
Serve però una classe politica e dirigenziale capace di andare al di là dell’adeguamento alla prassi consolidata e all’innovazione a parole, e dotata di una visione e della volontà di sperimentare soluzioni nuove. La scuola è importante. Di crescita non ce n’è una seconda. Un ragazzo, una giovane crescono una volta sola nella vita e gli adulti dovrebbero sentirsi in dovere di offrire loro il meglio
Foto. Angelo Gennaccaro e Leonardo Colletti