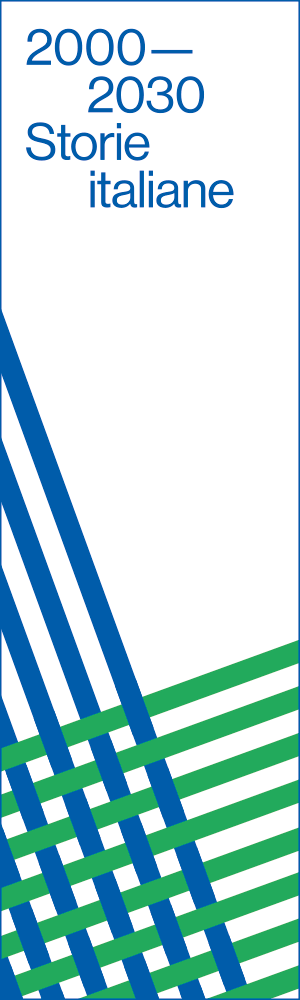L’Amarone della Valpolicella è tra i più prestigiosi vini rossi italiani. Un vino da servire nelle grandi occasioni, da abbinare a piatti importanti o come vino “da meditazione”.
Sin dai tempi dei Romani fino alle tavole regali dell’Ottocento, i vini più importanti erano dolci. La Valpolicella non faceva eccezione ed era già famosa nell’antichità per i suoi vini da appassimento, grazie alle peculiari caratteristiche delle uve autoctone e del clima. Accanto al vino secco quotidiano, il Valpolicella, era tradizione delle famiglie che possedevano campi e vigne produrre il Recioto, scegliendo i grappoli migliori e di essi la parte migliore, “le recie”, le orecchie, dove gli acini sono più esposti al sole e quindi più ricchi. Le cassette piene d’uva venivano trasportate in cantina e impilate all’interno di grandi stanze dette fruttai, di solito collocate sotto i tetti delle aziende agricole o in speciali edifici costruiti vicino alla cantina o al vigneto. Le uve si facevano appassire per alcuni mesi sulle arele, speciali graticci in cannucciato o listelli di bambù, controllate quotidianamente per verificare che ogni acino fosse sano e poi vinificate in gennaio oppure in febbraio. Il momento principale era la ermentazione, facendo attenzione al ribollire del mosto per non perdere il momento giusto per bloccarla esponendo le botti al freddo invernale. Si otteneva così un vino molto dolce ma di estremo equilibrio grazie all’elevata acidità di base. Le rese molto basse ne facevano un prodotto straordinario. Il Recioto era il vino della Pasqua. Capitava però, non di rado, che per disattenzione la fermentazione scappasse e gli zuccheri venissero svolti del tutto, lasciando nelle botti un vino secco. Il Recioto non era più tale, diventava il “Recioto scapà”, cioè scappato. Era così che si chiamava inizialmente questo vino sbagliato, considerato appunto scappato, sfuggito di mano.
Solo successivamente gli venne dato il nome Amarone, perché il contrario di dolce é amaro. Non era una bella sorpresa per chi lo faceva: fino agli anni Quaranta veniva venduto addirittura a un prezzo più basso del Valpolicella!
Talvolta, l’Amarone nasceva però anche da un errore durante la maturazione dell’uva sulla pianta. In certe annate fredde succedeva che non si riusciva a rispettare a sufficienza i parametri di surmaturazione, gli acini non raggiungevano un contenuto zuccherino abbastanza elevato da subire un arresto di fermentazione, quindi non si trasformavano in un’intensa dolcezza. Accadeva che tutti gli zuccheri diventavano alcol, quindi il vino ottenuto non era più dolce, o amabile, ma diventava secco e asciutto.
Recioto, Amarone e tutti i vini DOC Valpolicella sono fatti con la stessa composizione di vitigni autoctoni. Crescono solo in Valpolicella e sono il risultato della selezione delle varietà più adatte a questo territorio in più di 2000 anni di produzione vinicola.
Le uve principali dell’Amarone sono Corvina, Corvinone e Rondinella. Corvina e Corvinone insieme devono essere presenti in percentuali comprese tra 45% e 95%, la Rondinella tra il 5% e 30%. Solo il 40% delle uve totali di un vigneto può essere selezionato per la produzione dell’Amarone. Si possono anche aggiungere piccole quantità di altre uve locali come Molinara (un tempo era obbligatoria), Oseleta, Dindarella, Negrara, Pelara, Spigamonti, etc, e in ancor più piccole quantità alcuni vitigni nazionali e internazionali.
A Verona, tipicamente l’Amarone si abbina alla “pastissada de caval” (lo stufato di cavallo), alle fettuccine con il ragù d’asino o anatra, al bollito misto con salsa pearà, al formaggio Monte Veronese stravecchio. Può essere l’ingrediente pregiato per un Risotto all’Amarone.
Tornando al Recioto, narra la tradizione che in un tardo pomeriggio dell’aprile 1320, il Conte di Valpolicella, seguito da fedelissimi cavalieri d’arme e da dignitari prescelti per merito, si recò in processione presso il fastoso Castello di Marano, presso il minuscolo tempio di S. Maria Valverde. Qui, di fronte alla infinita distesa dei vigneti e dei ciliegi in fiore, egli procedette alla investitura dei primi dignitari Cavalieri del Recioto. Nasceva idealmente ciò che oggi è lo S.N.O.D.A.R. (Sovrano e nobilissimo ordine dell’Amarone del Recioto). Da allora la manifestazione ogni anno si rinnova ancora nella suggestiva cornice della Chiesetta di S. Maria della Valverde, presso la Contrada Pezza di Marano, a pochi passi dai ruderi dell’antico maniero di Federico della Scala, nel luogo stesso che era stato testimone, 650 anni innanzi, dell’investitura dei primi nobilissimi Cavalieri del Recioto.
Chi scrive è stato investito dallo S.N.O.D.A.R. del pregiato titolo di “Cavaliere dell’Amarone e del Recioto”.