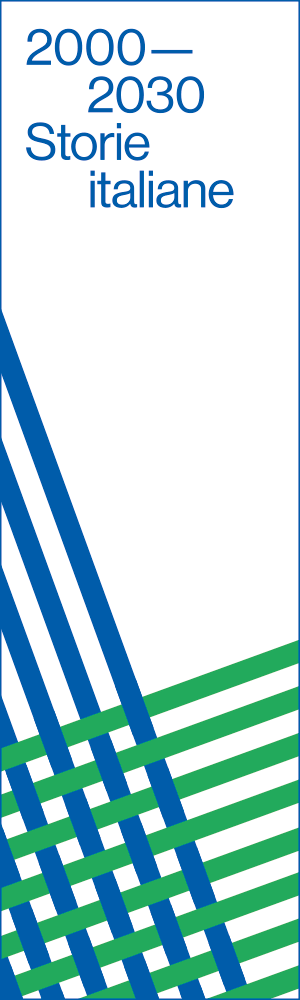È stata, quella dell’altra sera al Teatro di S. Giacomo, un’occasione preziosa per focalizzare il tema quanto mai attuale dei cambiamenti climatici, complice la competenza in materia del noto climatologo Luca Mercalli. Il cui nome ha anche compiuto il piccolo miracolo di riuscire ad affollare l’auditorium in una giornata ricompresa nientemeno che nel lungo weekend di Pentecoste. Bene così, vista la causa in ballo.
Hanno dato il ‘la’ alla serata il vicepresidente della Giunta provinciale Giuliano Vettorato e il sindaco di Laives Christian Bianchi, con considerazioni su temi fra cui il Piano Clima della Provincia Autonoma di Bolzano e la riqualificazione energetica (Vettorato), il necessario impegno del singolo nel campo della ‘sostenibilità’ e la particolare sensibilità mostrata dai giovani (Bianchi), con tanto di menzione di due classi della scuola media Filzi di Laives, vincitrici di un concorso provinciale proprio sulla sostenibilità. A seguire, l’assessore all’ambiente del Comune di Laives e ideatore delle “Giornate della Sostenibilità” del Comune stesso, Bruno Borin, ci ha tenuto a evidenziare gli sforzi fatti dall’amministrazione municipale nel campo della tutela dell’ambiente, e ha illustrato le iniziative attuate e in via di attuazione avendo come obiettivo il contenimento dei gas serra.
Poi, il momento tanto atteso dal pubblico: l’arrivo sul palco di Luca Mercalli, presidente della Società meteorologica italiana, il quale si è reso interprete di un intervento pacato e appassionato al tempo stesso. E articolato. Nonché denso di riferimenti a dati che ci ha tenuto a sottolineare essere scientifici e reali.
La prima parte della dissertazione è consistita in una significativa disamina sugli eventi climatici estremi verificatisi dalla sua precedente presenza a San Giacomo, nel 2017, al presente.
Solo per citare alcuni dei punti, esemplificativi della lunga carrellata proposta dal ricercatore:
⦁ la tempesta Vaia dell’ottobre 2018, con lo scirocco a 170-200 km/h e milioni di alberi sradicati;
⦁ la eccezionale acqua alta a Venezia nel 2019 – fenomeno sempre più frequente, ha detto, sia in quanto il terreno sprofonda sia perché di pari passo sta salendo il livello del mare (che aumenta su scala mondiale di 4,5 mm l’anno a causa dell’espansione termica delle acque dovuta principalmente alla fusione dei ghiacci in Groenlandia);
⦁ il 2020 con uno degli inverni tra i più miti del secolo e, d’estate, un susseguirsi di tempeste, alluvioni, colate detritiche;
⦁ il record nazionale di pioggia del 2021 a Genova e dintorni (882 mm di precipitazioni in una sola giornata);
⦁ il dramma del luglio 2022 sulla Marmolada, dove – ha spiegato – dopo giorni di zero termico oltre i 2000 metri il caldo ha fuso una grande quantità di ghiaccio sopra a un lembo non particolarmente a rischio, e l’acqua penetrata in un crepaccio ha letteralmente scollato una imponente porzione del ghiacciaio;
⦁ la magra storica del Po nel 2022/23;
⦁ infine il mega-evento alluvionale ancora fresco di cronaca in Emilia orientale e Romagna, che ha interessato un territorio di ben 7.000 kmq – evento per il quale, ha specificato, solo grazie all’allerta tempestiva le perdite umane non sono state di molto superiori a quelle registrate.
Laddove alla domanda, da Mercalli auto-formulata: “colpa dei cambiamenti climatici”?, la sua risposta è stata… “NI”.
“Gli eventi estremi li abbiamo sempre avuti, sulla terra, da prima che ci fosse l’uomo”, ha precisato, “ma adesso il riscaldamento globale ci mette un carico supplementare: ne aumenta la frequenza e l’intensità”. Ha rimarcato, di questo caso recente, la straordinarietà dei due eventi a distanza ravvicinata, dove il primo di inizio maggio ha imbevuto i suoli, il secondo più intenso di metà mese ha fatto il resto. “Puoi aspettarti che accada una volta ogni 50 anni, invece: due volte in due settimane”, ha detto, spiegando poi che il riscaldamento globale fa evaporare più acqua dagli oceani, dato il maggiore caldo. E visto che nell’ultimo secolo la temperatura del pianeta è aumentata di circa un grado, è ipotizzabile – ragionando su un +7% di vapore acqueo per ogni grado di aumento – “che in tutto il mondo ci sia il 7% in più di vapore che circola nell’atmosfera: e da qualche parte deve cadere…”. Col che, quando si verificano le condizioni affinché si formi un qualche tipo di perturbazione, le piogge possono potenzialmente essere più abbondanti rispetto al clima più fresco di un secolo fa. “Ecco come si genera il meccanismo di amplificazione degli eventi estremi.”
Sul caso si è soffermato a lungo, in quanto espressione di una situazione complessa. Ad esempio, “gli argini progettati per il clima del passato non vanno più bene”, ha detto. Infrastrutture quindi da rivedere. E cattivo uso del territorio da correggere, fra l’altro non ricostruendo necessariamente tutto. Parola chiave della situazione che non va: cementificazione. “In quelle zone si è enormemente edificato negli ultimi cinquant’anni pur sapendo che erano a rischio”. Col risultato che “le troppe case (spesso, recenti lottizzazioni di villette / zone di nuova urbanizzazione) hanno aumentato il ‘capitale’ esposto.”
Altro aspetto inquietante: quello relativo ai circa 30.000 evacuati. Ampliando il discorso alla sfera mondiale, Mercalli ha dato conto anche delle cifre immensamente maggiori riferite ad esempio al Pakistan, dove nel 2022 le alluvioni hanno provocato 1.500 morti e 33 milioni di sfollati. “Migrazioni climatiche”, le ha definite. Paventando che in futuro i nuovi eventi estremi possano mettere in movimento centinaia di milioni di persone, con tutto quel che ne conseguirebbe in termini di dinamiche sociali e geo-politiche.
E il cambiamento climatico ne avrà verosimilmente per tutti, se è vero com’è vero – e come fatto notare dall’esperto – che anche un paese super-organizzato come la Germania, in occasione della disastrosa alluvione del luglio 2021, si è mostrato vulnerabile rispetto all’acqua.
La seconda parte dell’intervento, Luca Mercalli l’ha aperta con una considerazione. “Spesso si tende a minimizzare, o a dare dei catastrofisti ai climatologi – me compreso. Ma se l’uomo più importante del mondo sotto il profilo diplomatico, e cioè il Segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres, ingegnere e mente scientifica, utilizza a proposito del problema climatico espressioni come ‘codice rosso per l’umanità’, ‘bomba climatica a orologeria’ e altre dello stesso tenore, allora vuol dire che la situazione è veramente grave. E io ve lo confermo”.
Ha rammentato come la visione scientifica condivisa sul riscaldamento globale risalga addirittura, a prescindere dai negazionisti, agli anni Settanta. Poi tutta una serie di passi importanti, tra cui: costituzione nel 1988 dell’IPCC, l’organismo delle Nazioni Unite deputato a raccogliere informazioni sul clima terrestre e fornire rapporti e indicazioni super partes, Convenzione quadro delle Nazioni Unite Unfccc (1992), Protocollo di Kyoto (1995), e nel 2015 Accordo di Parigi: “un accordo che dovremmo rispettare ma non rispettiamo”, ha deprecato Mercalli. Ciò, mentre il grafico della temperatura terrestre riflette l’aumento di un grado nell’ultimo secolo e il relativo picco recente (in particolare negli ultimi due decenni).
Mercalli ha ricordato la temperatura eclatante di 49,6 °C a Lytton in Canada nel 2021, e il 2022 come anno più caldo nell’Europa sud-occidentale, con, tra l’altro, i 40 gradi registrati a Londra, l’acqua del Mediterraneo salita di ben 5 gradi oltre la media, la perdita in un solo anno del 6% del ghiaccio dei ghiacciai, rientrante a propria volta in una contrazione del 60% nell’ultimo secolo. “Questo vuol dire – ha osservato – che i nostri ghiacciai sono condannati alla scomparsa pressoché totale entro la fine di questo secolo; ci aspettiamo che rimanga un piccolo cappuccio di ghiaccio solo sul Bernina, sul Monte Rosa e sul Monte Bianco, mentre tutto quello che sta al disotto dei 4000 metri è destinato a sparire”. Con la conseguenza anche di acqua in meno nei fiumi.
Ma torniamo al riscaldamento globale. Causa l’aumento dei gas effetto serra, tradotto in riscaldamento della superficie terrestre, la simulazione a 100 anni mette in conto, come scenario ‘catastrofico’, un possibile aumento anche di 4-5 gradi a fine secolo della temperatura terrestre.
Lo scenario ‘prudente’ dice invece che intraprendendo ‘la cura’, si potrebbe limitare l’aumento a 2 gradi. “Uno lo abbiamo già preso – ha puntualizzato Mercalli – e l’altro è in canna, per l’inerzia di un sistema così gigantesco”. Insomma, guarire ormai non potremo, “visti i trent’anni di ritardo rispetto alla Convenzione del 1992”. Ma una transizione ben fatta, portando le emissioni a zero nel 2050 a livello globale, consentirebbe di piegare la curva e fermarla appunto intorno a +2 gradi a fine secolo, ritenuti ‘la soglia di sicurezza’ per le generazioni più giovani.
Abbiamo quindi “ancora un po’ di tempo, ma poco: se al 2030 non abbiamo cominciato a diminuire a livello mondiale le emissioni entriamo nella riga arancione (scenario catastrofico) e a quel punto diventa un’impresa quasi impossibile cercare di riportarci su quella azzurra (scenario prudente)”.
Laddove accanto all’aumento della temperatura va considerato quello del livello dei mari: con la relativa scomparsa dei territori via via a rischio.
Ulteriori aspetti: “il clima che cambia fa estinguere molte specie animali, la deforestazione dà un’altra batosta, l’eccesso di pesca negli oceani un’altra, l’inquinamento un’altra ancora: un milione di specie animali sono minacciate di estinzione, secondo lo studio delle Nazioni Unite sulla biodiversità (IPBES)”.
A proposito di inquinamento: la plastica che finisce nei fiumi, nei mari, e in parte si frantuma in microframmenti, ha invaso tutti gli ambienti del mondo.
E in una situazione già grave di suo, ecco una guerra… “che proprio non ci voleva, perché genera ulteriore inquinamento liberando gas serra con i mezzi militari; in più, spostiamo centinaia di migliaia di dollari dalla transizione ecologica agli armamenti”.
Infine il tema cruciale: QUALI LE SOLUZIONI?
“Ci sono, e sono state introdotte da seri programmi politici; cosa che soprattutto in Europa possiamo vantarci di fare in modo più organizzato e consapevole di tanti altri posti al mondo”, così Mercalli. “Il problema è che si fanno cose buone ma si continuano a fare quelle cattive. Purtroppo il ‘Grean Deal europeo’ (pacchetto di iniziative finalizzate alla transizione ecologica), continua a rimanere una bella slide, dove è indicato quello che dobbiamo fare. Ma non arriva a compimento, o ci arriva in piccoli esempi isolati”. Fra questi, ha menzionato un caso vicino al pubblico in sala: “Ci sono Comuni come Laives: consapevolezza, azione; ma tanti altri che invece se ne fregano. Lo stesso possiamo dire dei governi. E ci sono aziende all’avanguardia che si impegnano, altre che ne annullano il vantaggio”.
Quale il da farsi? Composita la ricetta per la cura, a detta del climatologo: “agricoltura con meno fitofarmaci, energie rinnovabili, trasporti sostenibili, sistemi finanziari che privilegino lo sviluppo delle tecnologie sostenibili, economia circolare, quindi riciclo dei rifiuti. Il tutto per arrivare a un’Europa neutra dal punto di vista delle emissioni entro il 2050”. Con tappa intermedia, però, assai vicina: il programma europeo ‘fit for 55’ dice infatti che al 2030 dovremmo aver raggiunto tagli per il 55% delle emissioni rispetto ai livelli del 1990. “Approssimando per praticità a una riduzione del 50% rispetto alle emissioni di oggi, abbiamo 7 anni per dimezzarle”. E dobbiamo farlo a suon di scelte efficaci e urgenti.
Portare a zero in tutto il mondo le emissioni al 2050, Mercalli stesso la vede come una sorta di ‘mission impossible’. E tuttavia non vuole lasciarsi prendere dal pessimismo nero: “una parte possiamo almeno tentare di abbassarla”. A cominciare dall’operato individuale.
Un pilastro è quello della casa a bassi consumi energetici. “E qui siete maestri: il modello Casa Clima, nato a Bolzano, ha fatto scuola”. Purtroppo, ha aggiunto, non ancora coi numeri su larga scala che sarebbero necessari per tagliare una fetta consistente dei consumi delle abitazioni, tenuto conto che in Europa il 40% dell’energia è usata per riscaldare o raffreddare le case.
Ma in tutti i casi: “pannelli solari a manetta, isolamento termico, vetri tripli, facciamo tutto quello che si può per efficientare le nostre case che sono dei colabrodo energetici.”
Poi la questione delle auto elettriche. “Lo so, non sono ancora in grado di accontentare tutte le esigenze, ma come tutte le tecnologie miglioreranno. Certo le dobbiamo caricare con le energie rinnovabili, sennò non serve a niente avere fatto la transizione, ed è chiaro che dobbiamo riciclare le batterie”.
Sul fronte alimentare l’indicazione dello scienziato è: mangiare meno carne. L’allevamento ha una sua responsabilità nella produzione di gas effetto serra, dato che alla CO2 dell’agricoltura intensiva si aggiunge il metano prodotto dai bovini. 80 chili di consumo di carne l’anno pro capite in Italia, si possono ridurre secondo Mercalli a 25, nell’ambito di una buona dieta mediterranea, cercando anche di orientarsi di più su carni che danno emissioni inferiori, come il pollo.
Infine, riagganciandosi a un punto precedente dell’esposizione: rispettare i beni non rinnovabili. “La cementificazione ci ruba il suolo e ci rende più vulnerabili nei confronti dei disastri climatici: è un flagello da fermare. Si ristrutturi quello che c’è, demoliamo e ricostruiamo meglio, ma trasformare suolo agricolo e boscato in edificato sarebbe qualcosa da non fare più. Quando mi viene chiesto cos’è la prima cosa che farei contro le alluvioni: la legge contro il consumo di suolo”.
D’impatto la chiusura della presentazione, dove nuovamente Mercalli ha preso a riferimento parole di António Gutierres: “We have a choice. Collective action or collective suicide. It is in our hands” / “Abbiamo una scelta: o un’azione collettiva (per raggiungere gli obiettivi) o il suicidio collettivo (lasciando tutto così). E la scelta è nelle nostre mani”. Al che, la sua sottolineatura è stata: “La parola di speranza la mette, ed è una speranza importante”.
Emblematica la chiosa dello studioso: “È tutto nelle nostre mani perché questo non è un disastro cosmico che ci arriva per qualcosa di deciso nell’universo, dove noi siamo degli spettatori a subire, guardando la catastrofe che arriva dal cielo.”
Il nocciolo, in fondo, è proprio qui: comportamenti che l’uomo ha perpetrato negli ultimi 200 anni, ma che ha ancora la possibilità di correggere. “Lo spazio di manovra è ormai un tempo breve, lo avete visto dai grafici, ma c’è ancora: altrimenti, semplicemente, cambieremo il mondo in un modo che sarà ostile a noi e alle generazioni future. E ne subiremo le conseguenze”.
Su queste parole, ecco scrosciare gli applausi più convinti e forti dell’auditorio all’indirizzo del relatore, prima di un’appendice lasciata all’assessore all’ambiente di Laives Bruno Borin. Il quale, oltre a rimarcare con orgoglio il 67% di energia rinnovabile che contraddistingue l’Alto Adige, ha definito l’importanza della serata – per quanto sentito da Mercalli – superiore a quella di mille telegiornali, dicendosi fiducioso che gli spettatori portassero a casa consapevolezze tali da indurre tutti a cambiare qualcosa.
Tradurre in pratica la ‘lezione’ di Mercalli. Ecco un proposito di quelli che possono fare la differenza.
Foto/c-FOTO CENTRO CULTURALE S. GIACOMO (co-organizzatore dell’evento)