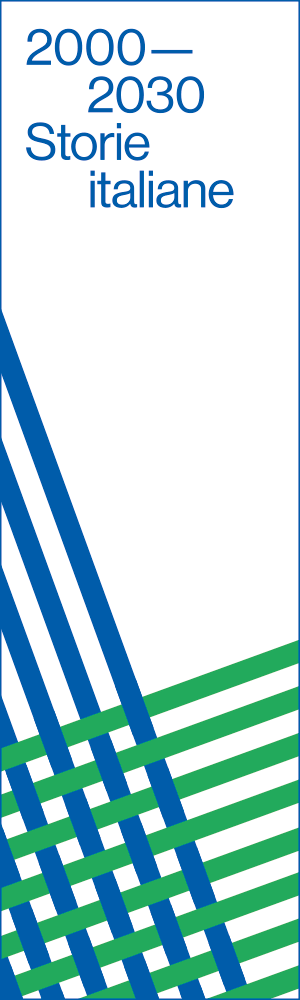Gli eventi degli ultimi anni stanno stravolgendo gli scenari della geopolitica mondiale. Tra conflitti sanguinosi – volutamente alimentati – le centinaia di miliardi sottratti allo Stato sociale per l’operazione ‘ReArm Europe’, il rischio della deindustrializzazione dei Paesi dell’UE, le speculazioni sui mercati dell’energia e le guerre commerciali che indeboliranno economicamente cittadini e imprese, la situazione si configura oltremodo problematica. Questo pure per il nostro Paese. Ne abbiamo parlato con Demostenes Floros, analista geopolitico ed economico, nonché docente a contratto presso il Master in Relazioni Internazionali d’Impresa Italia-Russia dell’Università di Bologna (momentaneamente sospeso dopo gli eventi del 24 febbraio 2022). Già responsabile di NE-Nomisma Energia, collaboratore per Abo e per la rivista WE-World Energy editi da ENI e per la rivista Limes, dal 2019 è Senior Energy Economist presso il CER (Centro Europa Ricerche). È stato inoltre Consigliere Economico del Consolato Onorario della Federazione Russa, a Bologna. Dal 2025-26 sarà docente a contratto di Geopolitics of Energy presso l’Università di Padova.
Dottor Floros, come ipotizzato da alcuni osservatori, con il ritorno di Trump si è iniziato a parlare di pace in Ucraina. Perché non si è fatto nulla per prevenire il conflitto e a che punto sono le trattative?
“Personalmente, non solo ritengo che non si sia fatto nulla per prevenirlo, bensì che si sia fatto di tutto per farlo scoppiare. E questo per tre ragioni. La prima: l’obiettivo principale della NATO, in primis degli Stati Uniti d’America, era quello di riportare la Federazione Russa ai drammatici Anni 90, cioè fondamentalmente uno Stato privo di sovranità nazionale, sotto il controllo degli Usa, dell’UE e del Giappone. La seconda: scindere il rapporto strategico tra Federazione Russa e Cina. La terza, voluta dagli Stati Uniti d’America con il supporto dei loro principali vassalli all’interno dell’Unione Europea (Polonia, Baltici): rescindere il rapporto commerciale ed energetico tra Federazione Russa ed Unione Europea. I primi due obiettivi, cioè il crollo della presidenza Putin, nonché del potere dei cosiddetti Silovikì, ripreso alla fine del’99 (in Russia, comandano gli apparati dello Stato, non gli oligarchi), e il venir meno dell’alleanza Mosca-Pechino, sono falliti. Il terzo obiettivo, quello della rottura tra Federazione Russa ed Unione Europea, è stato invece totalmente raggiunto. Per quanto attiene le trattative, che stanno procedendo dietro le quinte tra mille difficoltà, è bene chiarire che gli aspetti strettamente concernenti il conflitto militare in Ucraina (dal Donbass alla Crimea) sono certamente oggetto di discussione, ma non sono gli unici. Intendo dire che russi e statunitensi, dopo avere escluso dalle trattative i rappresentanti dell’Unione Europea, stanno discutendo su diversi dossier di politica internazionale, che vanno dal commercio, al rapporto con la Cina, alla sicurezza, passando per il prezzo del petrolio, nonché il ruolo del dollaro. Per essere chiari: Trump ha iniziato a parlare di pace in Ucraina non tanto perché sia realmente interessato al futuro di quel paese, o di quello che ne rimarrà, ma, per lo meno per quanto attiene il mio settore di competenza, cioè l’energia, perché ha la necessità primaria di riportare la Federazione Russa al sistema del benchmark Brent (il greggio di riferimento del mercato petrolifero mondiale, la cui centralità è oggi messa in discussione) e del pagamento del greggio in dollari. Per questo motivo, l’attuale Amministrazione Usa deve far cessare le ostilità in Ucraina quanto prima. Ovviamente, tutto ciò è molto più facile a dirsi che a farsi, visto che il maggiore ostacolo proviene da settori interni agli Usa, sostenuti da Bruxelles”.
Parliamo dell’origine del conflitto e di un aspetto perennemente ignorato: quello delle discriminazioni subite dalle minoranze russofone.
“In primo luogo, per origine del conflitto non si intende, ovviamente, il 24 febbraio 2022, bensì perlomeno il colpo di Stato del febbraio 2014. Anche se, molto probabilmente, bisognerebbe partire dai primi Anni 2000, quando una serie di “Rivoluzioni Colorate”, finanziate da “filantropi” occidentali, avevano già fatto intravvedere agli analisti più attenti la possibilità che il paese precipitasse nel caos, cosa purtroppo avvenuta. Dal febbraio 2014 al febbraio 2022 il conflitto, nell’est del Paese, ha portato ad almeno 15 mila morti, tra cui donne e bambini. Ovviamente, la minoranza russofona ha subito una serie di discriminazioni, a partire dall’impossibilità sostanziale di utilizzare la propria lingua. Desidero evidenziare che i russi, in Ucraina, erano circa 8 milioni (su 44 milioni di abitanti, prima del 2022); tuttavia, la lingua russa era utilizzata anche dalla gran parte degli ucraini e dalle minoranze non russe che vivevano nel Paese, le quali hanno subito forti discriminazioni da parte del regime filo-nazista che si è instaurato a Kiev. Tutto ciò è stato volutamente ignorato dal cosiddetto Occidente che, anzi, ha armato, finanziato e utilizzato le formazioni più revansciste – ucraine, ma non solo – per alimentare il conflitto. Vorrei ricordare, a tal proposito, il pogrom del 2 maggio 2014, presso la casa dei sindacati (a cui venne appiccato il fuoco, ndr), dove molti Ucraini antifascisti trovarono la morte in maniera atroce”.
‘ReArm Europe’: era davvero necessario investire 800 miliardi per la difesa da un nemico ipotetico? Qualcuno ritiene che il fine ultimo del progetto sia la creazione di un esercito europeo: se sì, con quali conseguenze per l’Italia e per l’Europa in generale?
“Condivido l’espressione di ‘nemico ipotetico’. Cerco di spiegarmi con un esempio comprensibile a tutte le persone di buon senso. La Federazione Russa ha pochi abitanti – non arriva nemmeno a 160 milioni (grave problema demografico) – ma dispone di tantissime risorse – fossili e non – nonché di riserve d’acqua, in un territorio praticamente sconfinato e in gran parte disabitato. Perché un paese con tali caratteristiche dovrebbe attaccare l’Europa centro-occidentale? È piuttosto curioso il fatto che quegli stessi politici e analisti occidentali che – giustamente – evidenziano tali pregi e limiti, siano gli stessi che ci mettono in guardia rispetto ad una imminente invasione della Federazione Russa. La contraddizione è evidente. L’esercito europeo? Faccio fatica ad immaginare un esercito europeo senza uno Stato europeo, rispetto al quale sono fortemente contrario. Com’è possibile creare un esercito europeo quando la politica estera ed energetica dei 27 Stati membri diverge quasi sistematicamente? Forse, è più facile che sia la Germania a riarmarsi: in barba – desidero ricordare – alle decisioni post ’45! La Germania ha livelli di indebitamento molto più bassi rispetto ad altri Paesi europei, tra cui l’Italia, ed è quindi molto più probabile che non vi sia un riarmo dell’Unione Europea, bensì un riarmo – in primis – di Berlino. Se così fosse, aumenterebbero le contraddizioni economiche all’interno dell’UEM, come abbiamo già visto negli ultimi 15 anni”.
L’operazione riarmo sottrarrà fondi destinati allo Stato sociale?
“Non c’è alcun dubbio che questa operazione sottrarrà fondi destinati allo Stato sociale. A dire il vero, lo hanno già dichiarato a Bruxelles, come pure esponenti del governo italiano. Più precisamente, la Primo Ministro Meloni, nonché il Ministro Giorgetti, hanno confermato l’obiettivo dell’innalzamento delle spese militari al 2% del PIL. Di fatto, ci è stato detto che non esistono i soldi per i salari, per la sanità e nemmeno per la scuola pubblica. Esistono, invece, per le armi”.
In una nostra intervista di maggio 2022, il fotoreporter Giorgio Bianchi ci disse, in riferimento al conflitto in Ucraina: “Perché le industrie non prendono alcuna posizione? Forse perché è stato prospettato loro un ruolo e, quindi, benefici derivanti dall’industria bellica? I “grandi” produrranno armi, i “medi” fungeranno da contoterzisti, mentre i “piccoli” verranno desertificati. Tutti i settori dell’economia saranno finalizzati al finanziamento dell’industria bellica”. In effetti sembra che l’automotive (attualmente in crisi nera) venga convertita in industria di produzione bellica.
“Condivido le osservazioni e le parole del fotoreporter, nonché amico, Giorgio Bianchi. A mio avviso, il tentativo è quello di uscire dalla crisi industriale che sta attraversando l’Unione Europea – in particolare, l’UEM – attraverso la riconversione di parte della nostra manifattura nel settore bellico. Tuttavia, almeno nel breve-medio periodo, ciò vorrebbe dire acquistare armi dai soli Stati Uniti d’America, o quasi. Dopodiché, mi chiedo se per caso si sono fatti i conti con la disponibilità di materie prime – fossili e non – a nostra disposizione. Mi pare un aspetto non indifferente; nutro forti dubbi che qualcuno lo abbia preso in considerazione. Vorrei inoltre evidenziare che in Germania, dato il tessuto industriale che la contraddistingue, la riconversione sarà relativamente più semplice, rispetto a quella degli altri Paesi, tra cui il nostro, la cui industria è fatta di PMI. Per cui, tutt’al più, per l’Italia, si prevedrebbe un ruolo di contoterzista. Discorso diverso per Leonardo, che senza dubbio potrebbe ricevere delle commesse favorevoli. Attenzione, però, perché l’ex Finmeccanica è stata pensata e costruita nell’ambito di una filiera produttiva alla cui cima stanno gli Stati Uniti d’America: si tratta, anche in questo caso, di un problema economico e politico non indifferente, per chi intende realmente intraprendere questa via”.
A proposito: nel 2022 Lei affermò che le sanzioni nei confronti della Russia avrebbero colpito aspramente l’Unione Europea e, in particolare, le manifatture di Germania e Italia, con il pericolo che si innescasse un processo di deindustrializzazione per questi Paesi. È ciò che è accaduto, alla fine, negli ultimi tre anni?
“Purtroppo quello che affermai nel 2022 si è realizzato. Per quanto riguarda l’Italia, infatti, abbiamo registrato il 25° mese di calo della produzione industriale: una situazione a dir poco drammatica che in pochi avevano immaginato. Per contro, in molti avevano ipotizzato soltanto due o tre settimane di “vita” per la Federazione Russa, che invece ha terminato il 2024 con una crescita del PIL del 4,1% e non dello ‘zero virgola’ come il nostro Paese e l’UE. Ciò non toglie che pure la Federazione Russa presenti una serie di criticità. Detto ciò, il punto fondamentale da evidenziare è che è venuto meno uno dei pilastri della politica neo-mercantilista dell’Unione Europea e cioè l’energia russa a basso costo”.
Che cosa vuol dire politica neo-mercantilista?
“Trattasi di una politica economica prevalentemente fondata sul traino delle esportazioni, sulla riduzione delle importazioni e della domanda interna, con una forte compressione dei salari reali, nonché dello Stato sociale. Questa politica – assolutamente da criticare – ha creato un forte squilibrio commerciale tra le due sponde dell’Atlantico – UEM in forte avanzo e Usa in forte deficit – ma non solo, al quale Trump sta rispondendo con la politica dei dazi. Il Presidente Usa, quindi, è la “conseguenza”, non la “causa” degli squilibri macroeconomici globali, le cui origini sono da ricercare nelle politiche libero-scambiste degli ultimi 35 anni, dove i capitali sono stati “liberi” di scorrazzare in giro per il mondo senza alcun controllo, come invece avveniva nel contesto della Guerra Fredda”.
L’origine dell’aumento dei prezzi delle materie prime non ha a che fare – come da Lei ripetutamente sottolineato in articoli e interviste – con il conflitto in Ucraina, bensì con la richiesta dell’UE – e non solo – di chiedere un cambiamento dei contratti (cioè della modalità di acquisto) del gas naturale. Dunque, in che termini si pone il problema?
“Gli organi di stampa di casa nostra hanno presentato l’incremento del prezzo del gas naturale nel mercato regionale europeo come la conseguenza dell’intervento militare della Federazione Russa in Ucraina, mentre i dati hanno rivelato che l’aumento – continuo e costante – del prezzo del gas naturale iniziò da marzo 2021. Come Centro Europa Ricerche (CER), abbiamo sempre sottolineato questo aspetto, sostenendo che la principale causa dell’aumento del prezzo del gas naturale fosse riconducibile al cambiamento intervenuto nella modalità di acquisto della materia prima, cioè nell’abbandono dei contratti di lungo periodo (financo trentennali), i quali prevedevano che il prezzo della materia prima fosse indicizzato a quello del petrolio (oil-link), adeguandosi con un ritardo di due/tre trimestri (contratti denominati take or pay). Ciò, sin dalla fine degli Anni 70, aveva garantito prezzi sostanzialmente stabili e forniture certe. Con il passaggio ai contratti gas-to-gas, il legame di prezzo gas naturale-petrolio, così come la durata di lungo periodo, vengono sostanzialmente meno, ed è il gioco della domanda e dell’offerta a determinare il prezzo nel mercato europeo (TTF), per giunta caratterizzato da pochissimi operatori, la gran parte dei quali aventi carattere speculativo. Come affrontare questa situazione? Francamente, è purtroppo molto complicato pensare di tornare indietro, come sarebbe a mio avviso giusto. Temo che siamo entrati in una nuova “era” dell’energia, i cui prezzi – a partire da quelli del gas naturale quindi, dei fertilizzanti e dei beni alimentari – saranno mediamente più alti rispetto a quelli registrati in passato. È bene evidenziare come tutto ciò sia stato fortemente voluto dai Paesi membri dell’Unione Europea e dagli amministratori delegati delle principali imprese dell’Unione Europea, mentre le società russe – a partire dalla Gazprom, fino al Cremlino – si erano nettamente opposte a questo cambiamento, per poi cedere alle volontà dell’Unione Europea. Volontà che è stata favorita da una serie di pressioni oltre oceano; oggi, tutti quanti abbiamo capito perché: di fatto, da chi acquistiamo il gas naturale liquefatto? Ma soprattutto, a quale prezzo?”.
In che modo i fattori geopolitici impatteranno sui mercati dell’energia? Con quali rischi per l’Europa?
“In merito all’impatto dei fattori geopolitici sui mercati dell’energia, ritengo in primo luogo che dipenderà da quale tipo di assetto si determinerà a livello internazionale. E cioè, se si porrà fine all’assetto unipolare NATO – post biennio ’89-’91, con gli Stati Uniti vincitori della Guerra Fredda e quindi egemoni a livello globale – oppure se, una volta chiuso questo assetto unipolare, nascerà un nuovo assetto multipolare. La mia impressione è che la vittoria militare della Russia in Ucraina determinerà la fine dell’unipolarismo statunitense e l’apertura di un mondo multipolare. Bisognerà però capire cosa si intenderà per ‘multipolarità’: sarà una multipolarità “imperiale” – come quella che, mi pare, abbia in mente il presidente statunitense – oppure un ‘multilateralismo’, come sostengono -almeno a parole – i cinesi? Credo inoltre che molto dipenderà anche dall’evoluzione della cosiddetta organizzazione BRICS plus, cioè i Paesi BRICS – Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica – i quali, dal 1° gennaio 2024, hanno aperto a nuovi membri, tra cui grandi produttori di energia, nonché grandi possessori di materie prime come Iran ed Emirati Arabi Uniti. E ancora, molto dipenderà dall’evoluzione della cosiddetta organizzazione OPEC plus, cioè l’unità dei Paesi OPEC e non-OPEC, questi ultimi capitanati dalla Federazione Russa. Oggi, l’OPEC plus controlla buona parte del mercato petrolifero, producendo quasi la metà dei 100 milioni di barili di petrolio che consumiamo tutti i giorni, delle esportazioni, oltre alle principali riserve, anche per quanto attiene il gas naturale. Questa Organizzazione nacque nel 2016 sulla scia dell’allora vittoria militare della Federazione Russa in Siria insieme all’Iran ed Hezbollah. Sappiamo però che la situazione in Siria è fortemente cambiata nel corso degli ultimi mesi e vedremo se ciò avrà ricadute anche sul suo futuro”.
Nel frattempo è scoppiata la guerra dei dazi: quali effetti per l’Italia e come potrebbero cambiare i rapporti tra Europa e USA?
“In primo luogo vorrei evidenziare che stiamo assistendo ad uno scontro feroce in seno al potere politico statunitense, espressione della medesima classe sociale dominante nel paese. I rapporti tra UE ed Usa evolveranno in base all’esito di tale conflitto. L’Italia è un paese fortemente esportatore, soprattutto – ma non solo – nei confronti degli Stati Uniti d’America e quindi il rischio che una guerra dei dazi colpisca la nostra economia – se non interverranno nuove misure che vadano in direzione opposta – è concreto (soprattutto, se gli Usa riusciranno ad imporre il “disaccoppiamento” tra i paesi UE e la Cina in ambito commerciale). Detto ciò, a prescindere dai dazi, desidero evidenziare che l’Italia ha una dipendenza energetica dall’estero attorno al 75% dei nostri consumi di energia primaria, per cui la bolletta energetica che dobbiamo sostenere è molto più alta rispetto a quella sostenuta da altre economie dentro e fuori l’UE. Inoltre, l’Italia, come l’Unione Europea nel suo complesso, sta rimanendo sempre più indietro da un punto di vista tecnologico (paradigmatico il settore dell’automotive). E ancora, in merito al tema della transizione energetica, ad esempio, al di là delle diverse visioni sul tema, vorrei ricordare che il 52% dei brevetti sulle rinnovabili depositati a fine 2023 è made in China; gli Stati Uniti si attestano poco sopra il 10%, mentre l’Unione europea poco sotto il 10%. Al di là di come evolverà il conflitto in seno al potere statunitense, il quale permane l’elemento centrale da cui partire, la mia impressione è che il nostro paese sia diventato incapace di pensare, di programmare di immaginare un futuro quindi, di avere una propria politica estera autonoma, perlomeno pragmatica, che tenga conto delle nuove realtà presenti soprattutto in Asia, a cominciare dalla Cina. Purtroppo, non vedo, né una classe borghese italiana in grado di avere una propria progettualità, come invece avveniva – seppure tra mille contraddizioni – nel contesto della Guerra Fredda, né un mondo del lavoro capace di stimolare il progresso del paese attraverso il proprio protagonismo. Ad oggi, nessuna classe sociale ha di fatto la capacità di essere portatrice anche di interessi generali, e non solo particolari. E questo purtroppo lo pagheremo in termini di peggioramento delle nostre condizioni di vita materiali ed immateriali”.
Ancora una strage -di cui il mainstream non parla quasi mai- viene consumata a Gaza: i bombardamenti israeliani hanno raso al suolo scuole e ospedali, nonché massacrato decine di migliaia di Palestinesi, tra cui numerosissimi bambini. Chi potrebbe fermare questo genocidio -accusa lanciata ad Israele da parte della Corte penale internazionale, dell’ONU, di alcuni governi nazionali e di varie organizzazioni non governative-, seguito ai fatti di sangue del 7 ottobre 2023, ad opera di Hamas? Qual è il piano geopolitico sotteso a tutto questo?
“Non c’è alcun dubbio che, se gli Stati Uniti volessero, fermerebbero la guerra in due minuti. Anche l’Unione Europea potrebbe fare molto al riguardo, ma non ne ha la volontà politica. E qui emerge il doppio pesismo dell’Unione che, rispetto al conflitto ucraino, si comporta in una certa maniera, mentre rispetto a quello in Medio Oriente in un’altra. Ciò – mi creda – sta producendo una serie di ripercussioni negative nei confronti di gran parte del resto del mondo di cui non siamo minimamente consapevoli. L’obiettivo della politica sionista di Israele è, ovviamente, la creazione della ‘Grande Israele’. Ma attenzione, perché esiste anche la volontà da parte degli Stati Uniti di ridefinire, parallelamente, il Medio Oriente, alla luce del fatto che negli ultimi anni la Cina, ma anche la Federazione Russa, hanno fortemente avanzato la propria influenza in questa zona del pianeta. L’auspicio, quindi, è che questi ultimi – membri del Consiglio di Sicurezza dell’ONU – possano quanto prima favorire la fine della mattanza del popolo palestinese”.