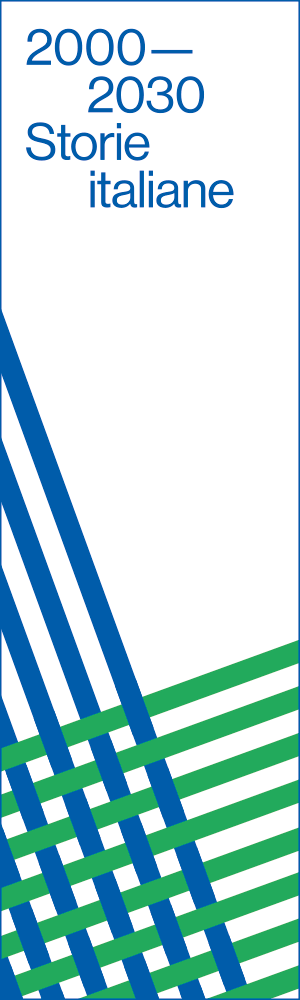Capaci 23 maggio 1992.
Il mare luccica sotto il sole caldo di Sicilia, l’aria profuma di primavera e sembra un giorno qualsiasi all’apparenza.
Giovanni Falcone, magistrato antimafia, era appena atterrato a Punta Raisi, l’aeroporto di Palermo, insieme a sua moglie Francesca Morvillo.
Ad aspettarli all’uscita dell’aeroporto c’era la scorta con i motori e i lampeggianti accessi pronti a partire.
Li attendeva un viaggio breve, sull’autostrada A29, insieme ai poliziotti Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro, un percorso abituale che facevano per recarsi a Palermo.
Ma quel giorno, qualcuno aveva deciso che Falcone non sarebbe arrivato alla sua destinazione.
Alle 17:58 un’esplosione devastante lungo l’autostrada.
Circa 500 kg di tritolo posizionato sotto il manto stradale fece saltare l’asfalto, aprì una voragine, la terra tremò, il boato si udì a chilometri di distanza.
Polvere, fumo, macerie: in pochi minuti cinque vite furono portate via da quell’esplosivo.
Cosa nostra aveva colpito, senza esitazione, senza vergogna, anche grazie al silenzio di chi avrebbe dovuto proteggere Falcone, uomini di Stato, ma stranamente assenti nel momento in cui avrebbero dovuto intervenire.
Ma se i mafiosi volevano il silenzio, ottennero l’esatto opposto.
Tutta l’Italia fu colpita da un terribile shock: il dolore si trasformò in rabbia, poi in determinazione. La paura lasciò spazio al coraggio, alla voglia di cambiare, di non restare immobili davanti a quella barbarie.
La gente scese in piazza, le scuole iniziarono a parlare di mafia, le istituzioni capirono che non potevano più fingere di non vedere.
Quell’attentato non era solo un omicidio, era un vero e proprio messaggio.
La mafia voleva dimostrare che lo Stato non poteva avere ragione su di loro, che nessuno poteva opporsi a Cosa Nostra senza pagarne il prezzo.
Ma aveva sottovalutato il senso di giustizia e della legalità che alberga nell’animo del popolo italiano.
Meno di due mesi dopo, esattamente il 19 Luglio, un altro magistrato, nonché amico di Falcone, Paolo Borsellino percorse gli ultimi passi davanti alla casa della madre, in via D’Amelio.
Un’altra esplosione, un altro massacro, un’altra ferita.
L’attentato che portò via Borsellino e la sua scorta fu un colpo tremendo, ma ormai qualcosa era cambiato nell’aria densa dell’odore pesante del tritolo.
Capaci e via D’Amelio, non solo stragi di mafia, ma furono anche il segnale che non si poteva più tornare indietro.
Da quelle tragedie nacque qualcosa.
Nuove leggi, nuove strategie di contrasto alla criminalità organizzata e la nascita della Direzione Nazionale Antimafia.
Il Paese capì che la lotta alla mafia non poteva essere lasciata solo ai magistrati coraggiosi, ma doveva essere una battaglia collettiva di tutti, anche dei singoli cittadini.
Oggi, trentatré anni dopo, il ricordo di Capaci e via D’Amelio è ancora vivo.
Ogni 23 maggio e ogni 19 luglio, le piazze si riempiono, le scuole raccontano, le istituzioni commemorano.
Ma non basta.
Il vero modo per onorare Falcone e Borsellino non è ricordarli una volta all’anno, ma ogni giorno, nelle scelte che facciamo.
Abbiamo imparato davvero qualcosa? Siamo capaci di essere migliori? Di non abbassare la testa davanti alle ingiustizie e alle prevaricazioni?
Falcone diceva: «La mafia è un fenomeno umano e come tale ha avuto un inizio e avrà una fine».
La fine della mafia non è scritta. È nelle mani di tutti noi.
Foto, Giovanni Falcone e due uomini della scorta